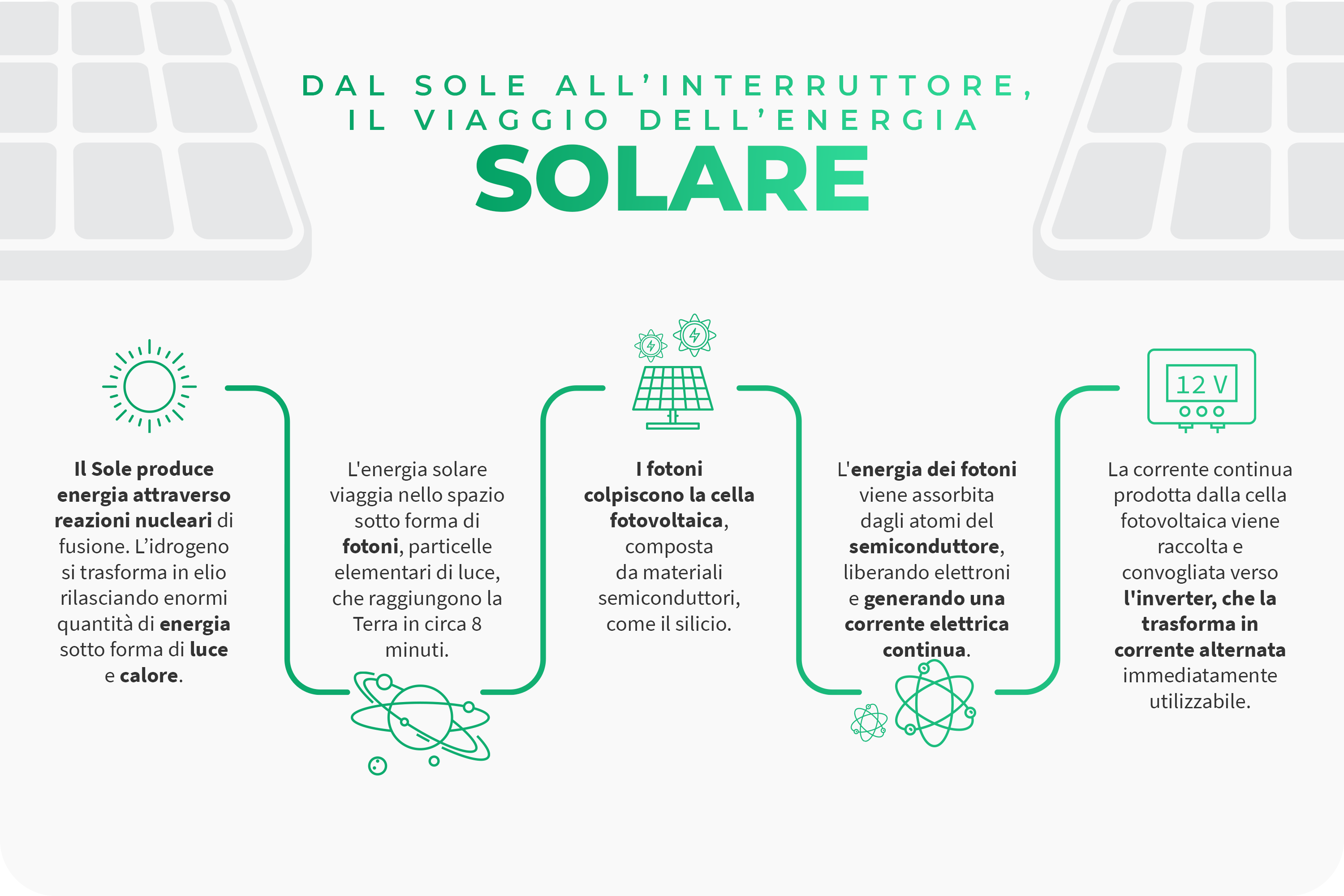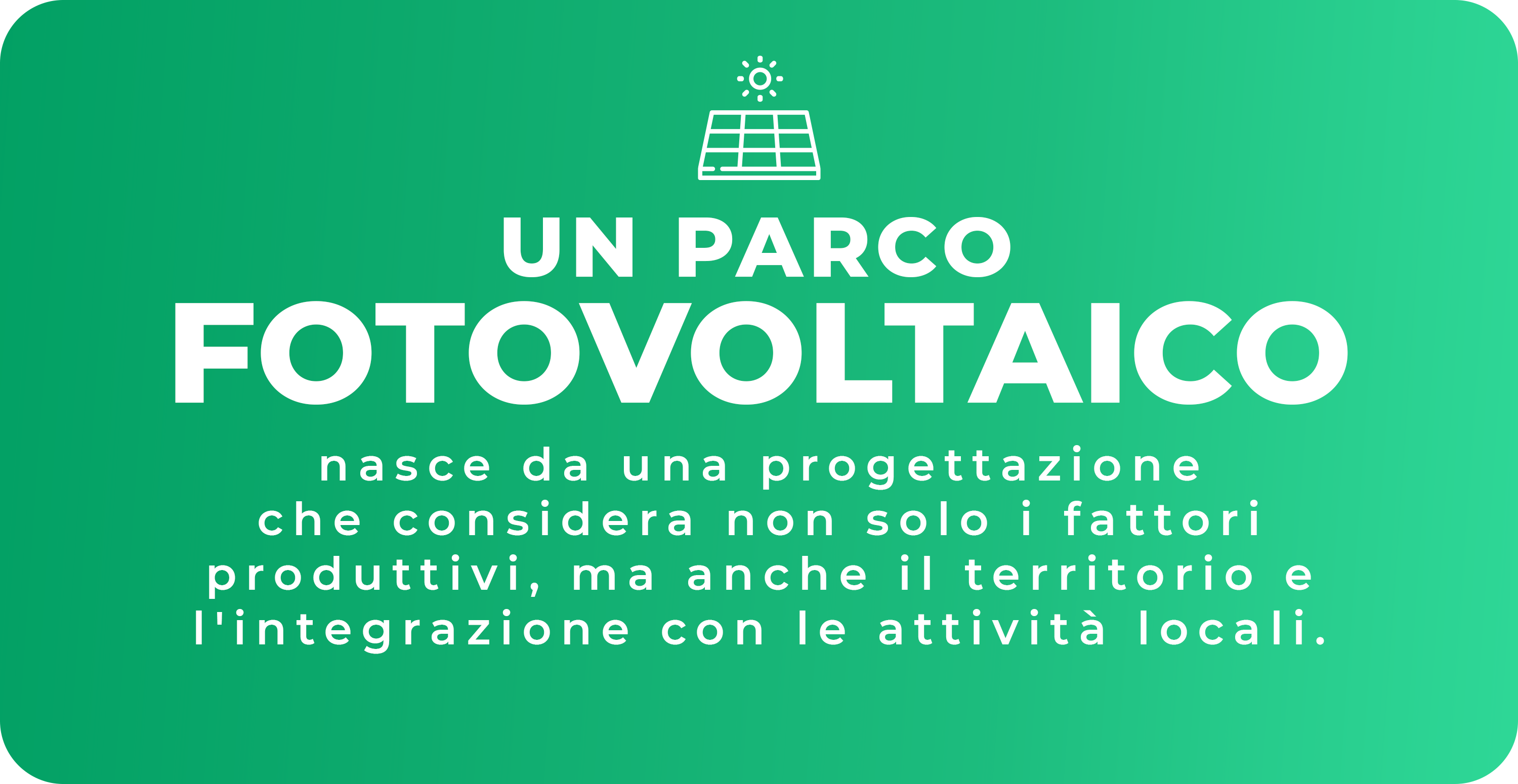Agricoltura e solare: binomio vincente
Agrivoltaico è il termine usato per descrivere l’installazione di parchi solari su terreni coltivati in modo che le due attività possano integrarsi. I pannelli vengono montati in alto così da essere meno invasivi oppure possono essere sfruttati per creare zone d’ombra utili ad alcune colture. Possono anche essere dotati di sensori per monitorare le condizioni del suolo e delle piante, ottimizzando l'irrigazione e la fertilizzazione. A Villarino De Los Aires, nella provincia di Salamanca, Plenitude ha avviato la costruzione di un impianto fotovoltaico, con una capacità installata futura di 220 MW, che, con una superficie di circa 286 ettari, sarà tra i principali della regione di Castilla y León.